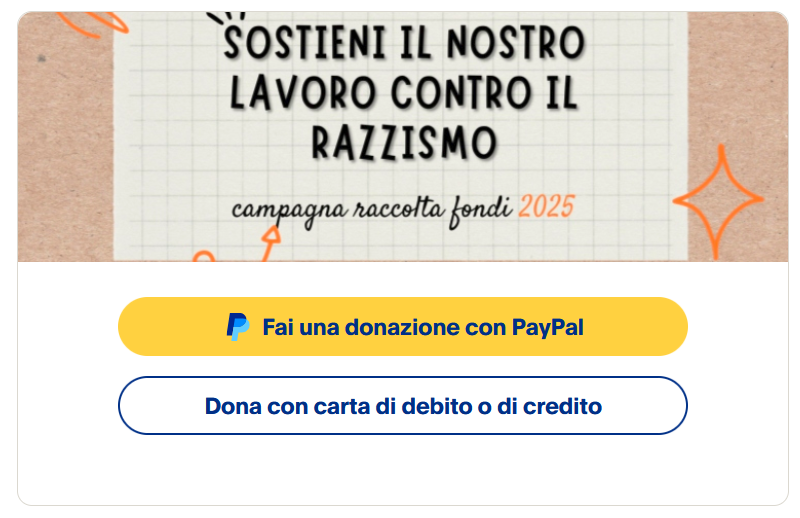Non solo un suicidio, ma l’ennesimo segnale di un problema più grande: Danilo Rahmi, cittadino tunisino di soli 17 anni, è morto il 13 agosto nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, in seguito ad un tentativo di suicidio, avvenuto pochi giorni dopo l’inizio della sua detenzione nell’istituto penale minorile.
Danilo era arrivato un anno fa in Italia, tramite la cosiddetta “Rotta Mediterranea” e rientrava in quelli che vengono definiti come “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA): cittadini minorenni di uno Stato non europeo o apolidi, che si ritrovano sul territorio nazionale senza l’assistenza o la rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
In Italia, al 30 giugno 2025, si registravano in Italia 16.497 MSNA, di cui la stragrande maggioranza era maschile (circa l’87%) e over 16 (76%) o di età compresa tra i 7 e i 14 anni (15%). I Paesi di provenienza sono Egitto (24%), Ucraina (19%), Gambia (9%), Tunisia (8%) e Guinea (6%), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (22%), la Lombardia (14%), la Campania (9%) e l’Emilia-Romagna (8%).
La storia di Danilo riflette l’estrema fragilità e vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, che subiscono discriminazioni sistemiche e sociali non solo in quanto migranti, ma anche in quanto minorenni.
Nonostante l’Italia abbia aderito a diverse Convenzioni Internazionali volte alla protezione dei cittadini minorenni, a prescindere dalla loro nazionalità, già nel luglio 2022 la Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) aveva condannato l’Italia per l’inadeguatezza dei servizi di assistenza rivolti ai MSNA. In particolare, il caso presentato alla Corte coinvolgeva un cittadino gambiano diciassettenne, Darboe Ousianou, che aveva denunciato fatti risalenti al 2016.
Nel suo caso, la Corte ha riconosciuto diverse violazioni delle Convenzioni Internazionali in materia di tutela dei minori, prima fra tutti l’erroneo riconoscimento di Ousianou come maggiorenne, che lo ha poi portato ad essere trasferito nel Centro d’Accoglienza di Cona, dove ha incontrato un sovraffollamento estremo e pessime condizioni igienico-sanitarie.
Gli errori nel riconoscimento della maggiore età sui MSNA non sono rari, poiché al momento non esiste davvero un metodo condiviso dalla comunità scientifica che consenta la determinazione dell’età anagrafica di un individuo. Il metodo promosso in Italia e riconosciuto anche a livello legislativo, chiamato “Greulich-Pyle”, prevede di determinare l’età tramite la valutazione della maturazione ossea del polso, ma in realtà presenta diverse problematiche: non solo ha un margine di errore di circa due anni (che può essere fatale per chi è over 16), ma i modelli di studio su cui si basa fanno riferimento ai corpi di adolescenti statunitensi bianchi degli anni Venti e Trenta, ben diversi da quelli della maggior parte degli attuali giovani migranti.
Il mancato riconoscimento della minore età di un cittadino MSNA può cambiare radicalmente la sua esperienza nell’accoglienza, con gravi violazioni nella sua tutela. Come, per esempio, sta succedendo nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano, in cui la rete di attivisti “No Cpr” ha segnalato la presenza di un diciassettenne, considerato erroneamente maggiorenne per via, appunto, dei risultati dell’esame Greulich-Pyle. Il ragazzo è da dieci giorni in sciopero della fame, per manifestare contro le condizioni disumane a cui è sottoposto: l’ospedale gli ha prescritto l’uso delle stampelle per un problema al piede, ma il Cpr non gli ha nemmeno fornito una stampella per camminare ed è ora costretto a letto in isolamento, senza un’assistenza adeguata.
Un’altra condanna della CEDU all’Italia arriva nel 2017, per il trattenimento illegittimo di alcuni minori stranieri dentro l’hotspot di Taranto. Anche in questo caso, la Corte sottolinea come le condizioni della struttura fossero inadeguate per le esigenze di una persona minorenne, con un grave affollamento e condizioni igienico-sanitarie precarie. Inoltre la sentenza evidenzia come i minori siano stati sottoposti a un trattamento degradante e inumano, senza poter accedere a un qualsiasi tipo di assistenza legale.
Non è la prima volta che segnaliamo come, nel tentativo di regolarizzarsi sul territorio nazionale, una persona immigrata sia soggetta a continue violazioni dei diritti e della propria dignità, ma questi fatti sono ancora più gravi quando l’individuo in questione è anche minorenne.
Da quei fatti del 2016 sono passati quasi dieci anni, ma, come sottolinea anche il XXXIII Rapporto Immigrazione 2024 di Caritas e Migrantes, la situazione non sembra essere granché cambiata, continuando a far prevalere una gestione di tipo emergenziale, che sembra peggiorare.
L’attuale governo, infatti, cerca di risolvere questi problemi di carattere sociale-giudiziario, non con un maggiore rigore nell’applicare un’effettiva tutela al minore, ma con una serie di rafforzamenti all’aspetto detentivo-punitivo della legislazione: con l’attuazione del Decreto Caivano del 2023, molte associazioni denunciano un peggioramento del sovraffollamento nelle carceri minorili (come a Treviso) e, di conseguenza, una minore protezione dei detenuti minorenni.
Un simile approccio si vede anche nella gestione dei Centri d’Accoglienza: una deroga del governo (legge 176/2023) permette la collocazione dei minori over 16 in strutture per adulti, in contrasto all’interesse superiore del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Teoricamente dovrebbero alloggiare in sezioni dedicate, ma nella pratica delle realtà sovraffollate dei Centri per l’Accoglienza, non è quasi mai possibile.
Nonostante con la legge n.47/2017 (Legge Zampa) si sia effettuato un tentativo di rafforzare la tutela nei confronti dei MSNA, equiparando ai minori di cittadinanza italiana per parità di trattamento ed esplicitando il divieto assoluto del loro respingimento alla frontiera, i problemi strutturali rimangono.
Per esempio, all’hotspot di Pantelleria, in cui è di recente stata denunciata una sistematica violazione dei diritti, è noto che siano collocati diversi minorenni, nonostante la totale assenza di spazi dedicati.
Nell’iter di tutela del cittadino MSNA il ruolo dei Comuni è fondamentale, in quanto è a questi che vengono delegate la maggior parte delle pratiche burocratiche, incluse quelle per la richiesta di permesso di soggiorno/protezione internazionale, ma il governo sta attuando una stretta finanziaria in tal senso.
È recente, infatti, la notizia di una riforma al Fondo per l’accoglienza dei MSNA, che limita molto il suo utilizzo da parte dei Comuni. E nonostante la legge 142/2015 prevedesse un totale rimborso agli enti locali per questo tipo di spese, i fondi del 2023 non sono stati ancora erogati in tutti i comuni, per un totale di 190 milioni di arretrati, portando a un progressivo collasso della rete di supporto.
Ai problemi di tutela finanziaria-burocratica, si aggiungono poi quelli di carattere sociale e culturale, che rendono le persone MSNA particolarmente vulnerabili alle situazioni di sfruttamento lavorativo e sessuale. Un report di Save the Children, evidenzia come, a livello globale, nel 2023 una vittima di tratta su tre fosse minorenne (con un aumento del 25% rispetto al periodo pre-Covid), con una netta divisione di genere per il tipo di sfruttamento: le ragazze costituiscono il 60% delle vittime di sfruttamento sessuale, i ragazzi il 45% di quello lavorativo. Restringendo il campo alla sola Europa, le vittime minorenni costituivano il 12% del totale delle vittime di sfruttamento, una percentuale destinata a salire, visto che oggi un bambino su sei vive in zone di crisi (si tratta della percentuale più alta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale).
Un altro dato preoccupante di questo report riguarda il numero di cittadini MSNA scomparsi, che vede l’Italia al primo posto: si tratta di 22.899 minori, che mostrano implicitamente come le persone MSNA siano abbandonate dalle istituzioni ed esposte al rischio di diventare bersagli di reti criminali, evidenziando anche le diverse lacune presenti nel sistema di identificazione e presa in carico del minore.
Inoltre, in Italia c’è uno sfruttamento dei minori peculiare che riguarda l’ambito domestico e i contesti informali, in cui le vittime spesso non sono riconosciute come tali.
Un quadro che si aggrava ancora di più quando la persona MSNA appartiene alla comunità lgbt+ e, quindi, spesso si trova a non poter nemmeno contare sulla comunità del proprio Paese d’origine, in cui spesso l’omosessualità è criminalizzata e/o stigmatizzata. Nonostante questa particolare categoria sociale sia una delle più discriminate al mondo, in Italia non esistono percorsi d’integrazione o linee guida dedicate di tipo istituzionale.
I progetti più recenti che cercano di potenziare la tutela verso i cittadini MSNA vengono soprattutto da enti privati o del terzo settore. Save The Children, per esempio, sta portando avanti “Nuovi Percorsi”, nato nel 2021 dedicato ai minori e alla madri sopravvissute alla tratta, e l’attivazione del numero verde Anti-Tratta, nonché l’erogazione del servizio “Doti di Cura”, che fornisce supporto ai percorsi di autonomia. Nel 2022 ha anche avviato il progetto Liberi dall’Invisibilità, che organizza laboratori artistici e di supporto scolastico-sanitario nella provincia di Ragusa.
Sempre nel 2022 l’Università degli Studi La Sapienza di Roma e l’Università degli Studi di Bari avevano dato vita al progetto FEELING, finalizzato alla formazione degli operatori sociali nel rispondere alle problematiche dei minori lgbt+ con background migratorio.
Da aprile 2023 a marzo 2025 Save the Children ha cofinanziato il Progetto E.V.A. per facilitare l’identificazione precoce delle vittime di tratta e re-trafficking, in collaborazione con Spagna e Francia.
Iniziative senz’altro lodevoli e d’impatto significativo, ma per prevenire queste gravi violazioni dei diritti umani, occorre che le istituzioni si dotino di un approccio diverso alle migrazioni in generale considerandole non più come un fenomeno emergenziale, ma socialmente strutturale che richiede soluzioni altrettanto strutturate e di lungo periodo.