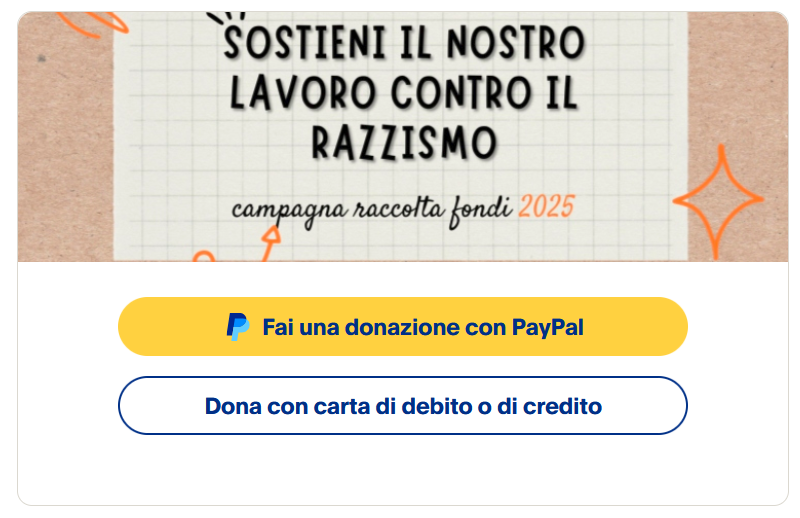Il 15 ottobre la Camera ha approvato formalmente la mozione presentata dalla maggioranza in favore del rinnovo del Memorandum Italia-Libia, bocciando invece le proposte delle opposizioni che chiedevano di fermare o rivedere il rinnovo. Il dibattito sulle politiche migratorie è spesso focalizzato sul momento dell’arrivo: le immagini dei porti, le imbarcazioni di fortuna colme di persone in difficoltà, le stragi nel mediterraneo. Ma i percorsi migratori inizia prima che le persone salpino verso l’Europa.
Di recente 140 persone – tra cui donne e bambini – sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera Italiana a 40 miglia da Pozzallo. Erano a bordo di un peschereccio, provenienti dalla Libia. Tre di loro presentavano ferite di armi da fuoco, uno in particolare – un ragazzo di quindici anni – è attualmente in coma dopo essere stato colpito alla testa. Ad aver aperto il fuoco prima dell’operazione di soccorso, stando ad un recente video diffuso da Alarm Phone e poi ripreso dalla Sea Watch, sono state le milizie libiche, le stesse che attraverso il Memorandum d’Intesa Italia – Libia, vengono finanziate dal nostro governo.
Questi episodi sembrano non riguardarci, sembrano lontani eppure ci riguardano da vicino a livello di responsabilità politica. Le immagini del presunto inseguimento da parte della nave libica di Saddam Haftar riaprono il dibattito sul Memorandum d’Intesa Italia-Libia, l’accordo triennale stipulato dal Governo Gentiloni nel 2017, oggi al suo terzo rinnovo e con il quarto all’orizzonte. L’accordo, ricordiamo, prevede una cooperazione per il contrasto alla cosiddetta migrazione illegale, attraverso fondi, mezzi e supporto tecnico e formativo fornito dal governo italiano alle autorità libiche affinché vengano fermate le partenze.
Nonostante nel dibattito politico il Memorandum sia sempre stato presentato come un accordo per la sicurezza delle persone migranti oltre che di ordine pubblico, dietro la scellerata retorica dell’”aiutiamoli a casa loro”, il Memorandum rappresenta la classica legittimazione della prassi di esternalizzazione delle frontiere. Con accordi bilaterali di questo tipo si delega a paesi terzi – spesso luoghi che costituiscono l’ultima tappa della migrazione prima di arrivare in Europa come Libia e Tunisia – la gestione delle politiche migratorie, sacrificando il diritto internazionale. Già nel 2017, all’indomani della stipulazione dell’accordo, ASGI denunciava come l’accordo fosse in contraddizione con la convenzione di Ginevra e negli anni sono stati tanti gli appelli per impedirne il rinnovo; non sono mancate nemmeno le denunce da parte delle Nazioni Unite che nei numerosi rapporti hanno documentato violazioni continue dei diritti umani, detenzioni arbitrarie e respingimenti illegali.
Negli ultimi anni – mentre l’Europa continuava a consolidare la prassi di esternalizzazione delle frontiere – le persone migranti hanno iniziato a denunciare le violazioni sistemiche subite. Tra queste voci c’è quella di Refugees in Libya, movimento nato nel 2001 che attraverso Report e Campagne di advocacy documentano, denunciano e rendono visibili le violenze sistematiche che accadono sia nei centri di detenzione libici che lungo le rotte di fuga. In particolare Refugees in Libya – che opera anche in Tunisia – ha sempre puntato il dito sulla complicità dell’Unione Europea e dell’Italia in particolare nel finanziare quelle autorità che gestiscono i centri di detenzione, chiedendo la fine del Memorandum Italia – Libia e l’apertura di corridoi umanitari.
Una voce che parte da chi la migrazione la vive, una presa di parola che mette in discussione quelle decisioni prese altrove: ora questa presa di parola politica arriva anche in Italia. In questi giorni, infatti si stanno svolgendo gli Action Days per la campagna Stop Memorandum Italia-Libia che culminerà con una manifestazione sabato 18 Ottobre alle 14.00 presso Piazza Vidoni, Roma.
Questo punto di caduta è importante per riaprire il dibattito sulle politiche migratorie e per costruire una nuova grammatica della migrazione che vada oltre la narrazione di arrivi e naufragi come se fossero delle eccezioni, anziché conseguenze di politiche sbagliate. La libertà di movimento, del resto, continua a restare il punto cieco delle politiche europee e mentre il vecchio continente si fa sempre più fortezza, dall’altra parte del Mediterraneo migrare si costituisce – inevitabilmente – come un atto politico di resistenza.