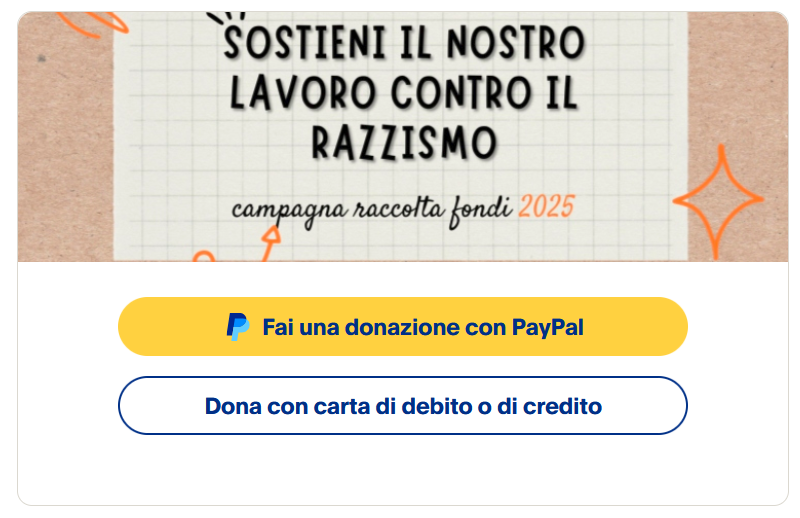Il recente omicidio di Charlie Kirk, attivista MAGA 31enne assassinato il 10 settembre scorso durante un comizio, e le reazioni delle destre istituzionali statunitensi e nostrane testimoniano come il linguaggio si sia fatto sempre più arma e allo stesso tempo spazio di conflitto. Non appena l’attivista MAGA è stato dichiarato deceduto nella sera del 10 settembre, tutti i politici, dal Presidente degli Stati Uniti alla nostra Presidente del Consiglio, hanno dichiarato che l’assassinio di Kirk è conseguenza dell’odio della sinistra. Nei giorni successivi altre voci hanno incalzato cercando di descrivere pedissequamente questo presunto “odio della sinistra” la quale sarebbe incline alla violenza, incapace di dibattito contraddittorio, intollerante verso le idee diverse dalle proprie.
Un ritratto che sembra ricordare un altro volto, quello che da sempre viene denunciato da chi si identifica con il mondo della sinistra. Difatti, quelle stesse caratteristiche per anni sono state imputate alla parte più conservatrice. Come ben notano in molti, tra cui Federico Faloppa della “Rete per il contrasto ai discorsi e fenomeni d’odio” in un’intervista per Radio Popolare, stiamo assistendo ad un ribaltamento di significato in cui le categorie di odio, violenza e “intolleranza” vengono ascritte a quella parte di mondo che viene identificata con la sinistra; una torsione semantica che sfrutta magistralmente anche fatti di cronaca nera per veicolare un messaggio atto ad indebolire le istanze portate avanti da movimenti antirazzisti, transfemministi, di solidarietà con la Palestina e per la giustizia ambientale.
Non è la prima volta in cui chi crede nei principi di uguaglianza e parità di diritti viene additato come violento; non a caso sono stati coniati termini come “nazitransfemminista” e si parla di “razzismo al contrario”, fino ad associare il termine “dittatura” al “politicamente corretto” in contrasto a chi (la destra) ha un “pensiero non allineato”. Oggi torna la seduzione da un’altra parola semplice: “odio”, perfettamente in continuità con la stessa strategia retorica.
Nel 2015 la Commissione Europea Contro il Razzismo e l’Intolleranza (l’ECRI) nella raccomandazione n.15 ha definito i discorsi d’odio come “il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale”. Più volte in questa sede abbiamo denunciato l’hatespeech messo in campo dalle destre, soprattutto istituzionali, che spesso hanno fomentato violenza contro le persone migranti e razzializzate, le donne e le persone non binarie.
Questa grammatica politica adottata dalle destre capovolge le cose attraverso un meccanismo che ricorda la proiezione freudiana in cui i soggetti attribuiscono ad altri i propri pensieri, desideri, spesso i più inaccettabili. Ma l’angoscia persecutoria che traspare dai discorsi messi in campo da intellettuali e politici non è un fenomeno individuale risolvibile con una seduta psicanalitica, ma una pantomima retorica architettata ad arte e interpretata da tutte le destre a livello internazionale, creando nuovi carnefici da una parte e nuovi martiri, nuovi underdogs, nuovi combattenti per la libertà d’espressione dall’altra.
Tuttavia i discorsi e i fenomeni d’odio agiscono come produttori di vulnerabilità sistemica perché basati su un’asimmetria di potere – politico e soprattutto mediatico – tale per cui ad influire non è solo il contenuto, ma anche la capillarità con cui questo viene diffuso. Questa capillarità non è data solo dalla presenza multipla delle destre istituzionali e intellettuali nei mezzi di comunicazione – giornali, televisioni, social, radio – e negli spazi di comunicazione – piazze, banchetti, cartelloni -, ma anche dall’assuefazione ad una grammatica linguistica e visiva violenta. Se il paragone ricorrente in questi giorni è quello relativo agli anni di Piombo, ciò che si dimentica è come l’attuale escalation di violenza e di “odio” sia sostenuto principalmente da un discorso polarizzante portato avanti proprio da chi ora si definisce martire della libertà d’espressione contro il pensiero unico. Se in un programma radiofonico un direttore di giornale afferma che vorrebbe sparare ai musulmani o se si continua ad inneggiare alla sostituzione etnica, il clima violento non verrà disinnescato dall’accusare come “portatori d’odio” chi solitamente ne è il principale bersaglio. Dietro l’evocazione del termine “sinistra”, lungi dall’indicare solo un qualsivoglia partito progressista, si nascondono prima di tutte le persone di differenti origini, con diverse espressioni di genere, spesso di bassa estrazione sociale, i cui diritti vengono sistematicamente negati.
Sembra quasi che la storia sia stata scritta a matita, come se fosse cancellabile tanto ciò che è accaduto cento anni fa con il nazifascismo, quanto i comunicati della Usgirai che denunciano come la televisione pubblica rischia di trasformarsi nel megafono del governo limitando sempre di più gli spazi in cui aprirsi ad un confronto con contraddittorio. Una gomma da cancellare passa anche sulle aggressioni di estrema destra che di sovente si subiscono alla fine di alcune manifestazioni, l’ultima avvenuta dopo un corteo a Roma contro il genocidio in Palestina.
La realtà racconta altro, dimostrandosi così complessa da non essere facilmente comunicabile quanto quella narrazione che ne compie oggi il ribaltamento. Tuttavia, in questi tempi così oscuri, proprio la storia non può essere dimenticata, soprattutto quando il suo capovolgimento di significato si pone come preludio della sua orrenda ripetizione.
Stefania N’Kombo José Teresa