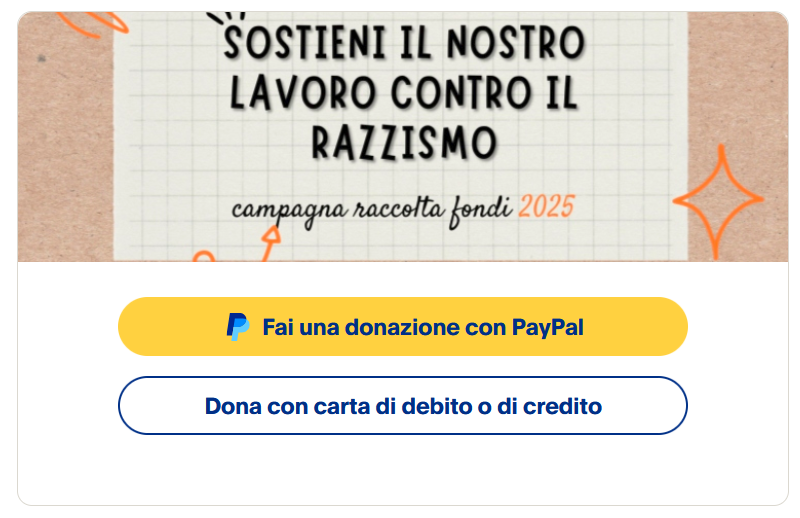Nei giorni scorsi, è stata messa online “Centri d’Italia”, la prima piattaforma con dati di dettaglio su tutti i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia curata da ActionAid e OpenPolis. Lanciato per la prima volta nel novembre 2018, “Centri d’Italia” nasce come progetto di monitoraggio sul sistema di accoglienza nel nostro Paese. In questi anni, sono stati pubblicati tre rapporti, fino ad arrivare a questa prima mappatura online dei centri mai realizzata prima in Italia.
La piattaforma, ricca di dati ed elementi di analisi, è configurata come un sistema integrato di informazioni riguardanti i posti disponibili nelle strutture, le presenze effettive, chi gestisce il centro, i prezzi giornalieri per la gestione, fino ai dettagli geolocalizzati del singolo centro, in ogni provincia e comune italiano.
Tuttavia, essa non riesce a contenere tutte le informazioni necessarie a fare un quadro completo della situazione. Mancano, purtroppo, i dati di alcuni indicatori importanti (che spesso le autorità competenti non forniscono, nonostante le numerose richieste inoltrate), come ad esempio i costi complessivi delle strutture di accoglienza, le anagrafiche degli enti gestori dei centri, oppure i dati disaggregati relativi ai centri per le annualità precedenti al 2020.
Poi ci sono i ritardi nelle pubblicazioni dei dati. Basti pensare che, a dicembre 2021, non risulta ancora pubblicata la “Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale” (che il Ministero dell’Interno dovrebbe presentare al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno, ndr) che consente di analizzare lo stato del sistema nel 2020.
Inoltre, il persistente rifiuto del Viminale a fornire l’accesso ai dati amministrativi sui centri di accoglienza presenti in Italia ha spinto sino alla presentazione di un ricorso al TAR del Lazio, che, con una importante sentenza del maggio 2020, ha confermato il diritto ad accedere a questi dati.
Tutti questi limiti sono stati esplicitati dai curatori del rapporto in una pagina dedicata.
Ma vediamo quali sono i dati salienti in questo report, nonostante queste lacune. Ci si potrebbe soffermare su tre assi portanti che delineano l’attuale paradossale situazione del sistema di accoglienza nel nostro Paese.
L’accoglienza si riduce ma resta prevalentemente “straordinaria”
Il primo dato che emerge è proprio quello di “un’emergenza che non c’è”: in tre anni, dal 2018 al 2020, le persone accolte in Italia sono diminuite del 42%. Solo nel 2020, i rifugiati e richiedenti asilo in accoglienza rappresentano lo 0,13% della popolazione italiana. E tuttavia, dobbiamo amaramente constatare che ancora 7 su 10 sono accolti in centri straordinari, perché il sistema di accoglienza continua ad essere basato su di una risposta emergenziale, oramai cronica.
In risposta alla diminuzione delle presenze, c’è stata anche una contrazione del 25,1% del numero di centri attivi sul territorio nazionale e del 40,2% dei posti complessivamente disponibili (il 46,8% in meno nel sistema Sprar/Siproimi). In termini assoluti, al 31 dicembre 2020, erano attivi 4.556 Cas, 4.570 strutture Sprar/Siproimi e 12 centri di prima accoglienza. Mentre, tra il 2018 e il 2020, sono stati chiusi 3.137 centri.
Un secondo ambito di analisi riguarda la dislocazione nelle città e ai limiti di capienza dei centri. Le 16 città più popolose – quelle con più di 200mila abitanti – ospitano il 18,2% delle persone, 2 anni prima questa percentuale era al 14,2%; in media i centri a Roma e Milano sono molto più grandi che nel resto del paese. A Milano la capienza media dei centri risulta circa 10 volte la media nazionale. Quindi, i centri di piccole dimensioni sono stati quelli più penalizzati (persi quasi 22 mila posti in due anni).
Costi al ribasso, diritti meno garantiti
Infine, un terzo livello di analisi, se pur carente di numerose informazioni, è quello relativo ai prezzi assegnati per la gestione dei centri. Tra il 2018 e il 2020, la cifra attribuita per le spese di vitto, alloggio e “servizi per l’integrazione” per ogni ospite nei Centri, passa da una media di 34,98 a 25,64 euro pro-capite al giorno, con un calo di 9,34 euro (26,71%). Anche in questo caso, a subire il maggior taglio sono i prezzi per i centri piccoli (-27%).
In particolare, 7 province del nord tra le prime 10 registrano la più netta diminuzione dei prezzi. Di queste, ben 4 sono lombarde: Mantova, Bergamo, Cremona e Milano che in due anni passa da un prezzo medio di 35,38 euro a 19,11 euro, con un calo pari al 46% dei prezzi necessari a pagare i servizi erogati per 2.270 posti disponibili in 37 CAS. Questo determina un ulteriore peggioramento delle condizioni d’accoglienza e dei servizi offerti, certamente non erogati nell’ottica dell’inclusione, ma seguendo la strategia del massimo ribasso dei costi.
I dati raccolti, seppur fermi al 31 dicembre 2020, dovrebbero far riflettere sugli effetti nefasti dell’applicazione dei cosiddetti “decreti sicurezza” varati nel biennio 2018-2019. Il rapporto evidenzia che, dal punto di vista normativo, alcuni passi avanti sono stati fatti grazie alla più recente delle riforme, quella voluta dalla ministra Lamorgese (decreto-legge 130/2020), che ha eliminato alcuni degli elementi più critici dei decreti sicurezza, reintroducendo ad esempio i corsi di lingua, i servizi di orientamento legale e l’assistenza psicologica nelle strutture straordinarie. Ma i limiti del nuovo modello rimangono molti.
Con la diminuzione degli sbarchi e la contrazione del numero dei CAS, si sarebbe potuto puntare sull’accoglienza diffusa e i piccoli numeri. Obiettivo non nuovo per un sistema di accoglienza sempre in affanno. E invece si è continuato a favorire le grandi concentrazioni nelle grandi città.
Si tratta, secondo Action Aid e OpenPolis dell’ennesima occasione persa per riformare il sistema e renderlo più efficace ed inclusivo. Una occasione persa che conferma la difficoltà del nostro paese (soprattutto della sua classe dirigente) nel riconoscere il carattere strutturale del fenomeno migratorio. Che non è “un’emergenza”.