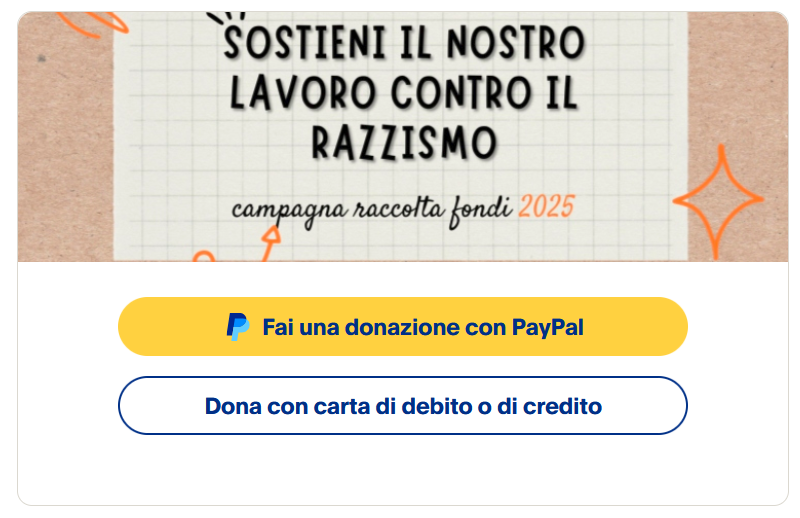“Questo è morto, dove lo metto?” In queste parole è racchiuso tutto il problema dello sfruttamento lavorativo dei migranti, la deumanizzazione e stigmatizzazione che le persone straniere sono spesso costrette a subire, anche in ambito lavorativo.
Questa frase è stata attribuita all’imprenditore Antonello Lovato, durante il processo alla Corte d’Assise di Latina, cominciato il 7 ottobre, per l’omicidio con dolo eventuale di Satnam Singh, il cittadino indiano ucciso nel 2024 per l’omissione di soccorso dopo che era stato tranciato da un macchinario agricolo e di cui abbiamo ampiamente parlato in passato.
Come più volte abbiamo segnalato, questi casi non sono isolati, ma sintomo di un problema molto ampio, che riguarda il modo di intendere il lavoro in Italia e di vedere il lavoratore dipendente come uno strumento-risorsa, piuttosto che come una persona. Visione che si aggrava quando il lavoratore in questione è straniero, intersecandosi col razzismo su più livelli: uno “personale”, proprio dell’imprenditore, e un altro sistemico, più ampio, che riguarda il modo di vedere le persone con background migratorio.
Lo dimostra anche solo il fatto che questo è un tema ciclico nella discussione pubblica italiana: i casi più gravi di sfruttamento arrivano sui media mainstream e riaccendono il dibattito sul tema. Lo sfruttamento agricolo è senz’altro quello che viene più facilmente coperto dai media, probabilmente anche per la grande importanza che questo settore ha nell’economia nazionale. Un caso recente riguarda l’incidente di Scanzano Jonico, in cui hanno perso la vita 4 lavoratori, cittadini pakistani, che erano stipati insieme ad altre 10 persone, dentro un’auto da 7, obbligate a fare 170 chilometri ogni giorno per andare a lavorare nei vigneti. Nonostante le indagini in corso, viste le condizioni in cui queste persone viaggiavano, è facile pensare che dietro ci possa essere la mano del caporalato o, in generale, condizioni di sfruttamento.
Le proteste di Rosarno: cosa (non) è cambiato dopo 15 anni
Questa storia è solo la punta dell’iceberg di un problema profondo e sistemico dell’economia italiana. Uno dei casi mediatici più famosi, almeno nella storia recente, ha riguardato le proteste di Rosarno nel gennaio 2010.
Abbiamo raccontato in maniera approfondita questa vicenda nella Quinta edizione del Libro Bianco, ma è bene ribadire come i braccianti in protesta per i soprusi subiti, sia a livello fisico con aggressioni che andavano avanti almeno dal 1992, sia a livello di condizioni igieniche e lavorative, avevano contro tutta la società italiana: in primis la comunità locale, con alcuni membri che organizzarono contro-proteste e ronde “anti-migranti”; poi i media, che dipinsero i lavoratori sfruttati come se fossero loro la causa del problema, e infine il sistema amministrativo italiano, che invece di proporre una soluzione a lungo termine, si limitò a deportare migliaia di persone nei centri di Bari e di Crotone. Lontano dagli occhi dei media e dei locali, così da nascondere il problema.
Una soluzione che non era davvero una soluzione, visto che, quindici anni dopo, a Rosarno, non è cambiato quasi nulla. Nel 2019, la baraccopoli c’era ancora e fu smantellata dal Ministero degli Interni, solo per essere sostituita da una tendopoli a San Ferdinando. Alberto Sanchioni in questo articolo fa una panoramica completa della situazione attuale: Emergency e MEDU denunciano le condizioni critiche, con una preoccupante mancanza dei servizi essenziali, che i lavoratori, maschi e per la maggior parte con un background migratorio, sono costretti a vivere. Qualche aiuto e soluzione virtuosa, proveniente da enti locali, c’è, come SOS Rosarno e l’Ostello eco-solidale Dambe So, che però può ospitare un numero massimo limitato di persone e deve comunque far fronte alle tensioni con la comunità locale, dato che continuano ad esserci aggressioni ai danni dei braccianti, una delle quali avvenuta proprio davanti all’ostello.
Bisogna anche riconoscere che, almeno a livello formale e legislativo, qualche sforzo è stato fatto, dal 2010 fino ad oggi. Nel 2011, con l’articolo 603 bis, è stata introdotta la fattispecie di reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, che mira, quindi, a colpire e contrastare il caporalato. Questa stessa legge è stata poi potenziata nel 2016, con l’estensione della responsabilità penale e amministrativa anche alle singole imprese che prevede anche atti di confisca e misure per una maggiore tutela dei lavoratori stagionali.
Nel 2020, poi aggiornato al 2023, si è approvato anche un Piano Triennale Nazionale per la prevenzione, vigilanza e protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo, con un focus particolare sul superamento degli insediamenti abusivi e la lotta al lavoro sommerso.
Infine, nel 2024, col Decreto-legge n.145, ha introdotto alcune norme volte a semplificare le procedure di regolarizzazione dei lavoratori e l’assistenza alle vittime di caporalato.
Tuttavia, queste misure non sembrano sufficienti a risolvere un problema così strutturale che interessa altri ambiti lavorativi. Tristemente nota è la situazione in ambito tessile e d’abbigliamento a Prato.
Lo sfruttamento nell’industria tessile a Prato
L’ultimo caso è avvenuto di recente, a settembre 2025: col supporto del sindacato Sudd Cobas, alcuni operai, quasi tutti provenienti dal Bangladesh, hanno protestato contro la decisione di delocalizzare l’azienda tessile per cui lavorano, che porterebbe a una riduzione della produzione interna e, soprattutto, dei posti di lavoro. La titolare ha reagito in modo estremamente violento. In un video diffuso dallo stesso sindacato, si vede la donna, supportata da un uomo, rincorrere, insultare e prendere a calci e pugni alcuni lavoratori, uno dei quali è poi finito all’ospedale.
Al contrario di quanto successo a Rosarno, qui la Procura di Prato ha almeno aperto un’inchiesta, ma la gestione dei rapporti con i lavoratori è la stessa: intimidazioni, violenze e repressioni delle proteste che vanno avanti da anni, sempre con la complicità della mafia (in questo caso quella cinese).
Un altro caso simile era successo l’anno scorso, durante le proteste avvenute nell’ottobre del 2024 che avevano coinvolto tutto il distretto tessile di Prato. Cinque uomini, italiani, si erano prima avvicinati al presidio, aggredendo con delle spranghe un sindacalista e uno studente, e poi avevano minacciato di morte i lavoratori presenti.
Il distretto tessile di Prato è il più grande d’Europa, ma molte aziende, gestite principalmente da imprenditori italiani e cinesi, applicano un sistema di sfruttamento della manodopera. In particolare, durante quelle proteste e secondo le denunce fatte ai sindacati, gli operai lamentano turni di lavoro troppo lunghi (circa 12 ore al giorno da lunedì a domenica), con contratti part-time non rispettati o totalmente in nero, in aggiunta al ricorso da parte dell’azienda a pratiche illecite, come la richiesta di restituire la tredicesima, o la mancata ricezione la busta paga in maniera regolare.
L’altro lato della Gig Economy: lo sfruttamento nel food delivery
Condizioni di lavoro e sfruttamento che caratterizzano anche la Gig Economy, ovvero quella parte del mercato del lavoro, per lo più occasionale e temporaneo, gestito tramite le piattaforme digitali.
Secondo il recentissimo XXXIV Rapporto Immigrazione 2025 di Caritas e Migrantes, si tratta di un settore fortemente precarizzato: i contratti sono spesso a termine o a chiamata e l’attività lavorativa è coordinata tramite piattaforme digitali. Il numero dei lavoratori si aggira intorno ai 2,2 milioni. Svolgono lavori come le consegne a domicilio (nello specifico di Food Delivery), trasporti urbani, facchinaggio e piccole manutenzioni, oppure completamente svolti da remoto, tramite micro-attività digitali (crowdwork) per conto di aziende o privati.
Nonostante la difficile reperibilità di dati attendibili sulla provenienza della manodopera, si stima che i lavoratori stranieri siano una quota importante, se non maggioritaria: per esempio, secondo un report di Nidil CGIL, si stima che a Milano costituiscano circa il 70% e siano provenienti da Bangladesh, Pakistan, Marocco e Nigeria.
Secondo un’altra ricerca della Banca d’Italia, i lavoratori stranieri nel food delivery sarebbero circa il 23%, con un’età media di 25 anni e una durata dell’impiego che dura meno di due anni. I lavori della gig economy sono spesso definiti flessibili, ma dietro questo concetto, all’apparenza positivo, si celano in realtà condizioni di lavoro precarie: un reddito mensile basso, con paghe che si aggirano intorno ai 2-4 euro a consegna e con il 30% dei lavoratori che guadagna meno di 800 euro al mese; assenza di tutele e benefit aziendali, con oneri economici scaricati sui lavoratori circa contributi e strumenti necessari; turni di lavoro che vanno fino alle 10 ore al giorno per 7 giorni della settimana.
In questo contesto, la condizione migratoria diventa per i lavoratori stranieri un ulteriore problema, in quanto la precarietà del lavoro spesso impedisce di trovare una stabilità economica e una conseguente regolarizzazione dello status giuridico.
In particolare, il Rapporto Fairwork Italia 2024 fa un’analisi approfondita delle piattaforme digitali più diffuse in Italia, tra le quali, per quanto riguarda il food delivery, Just Eat, Glovo e Deliveroo, dando loro un punteggio in base alla retribuzioni, le condizioni lavorative, equità dei contratti e della gestione delle relazioni con i lavoratori e della rappresentanza.
Di queste tre, solo Just Eat raggiunge gli standard minimi di tutela del lavoratore, mentre Glovo e Deliveroo risultano gravemente insufficienti (con un punteggio rispettivamente di 4 e 3 su 10). La differenza tra Just Eat e i suoi concorrenti dipende dal fatto che, dal 2021, stipulando un diverso accordo settoriale, la prima riconosce i suoi lavoratori come dipendenti e non autonomi, garantendo, dunque, la tutela di un contratto di lavoro collettivo. Di conseguenza, i lavoratori hanno accesso a tutele e garanzie aggiuntive, come accordi contrattuali basati sulle ore di lavoro effettive.
In merito al food delivery, l’Unione Europea ha approvato nel 2024 una Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, la quale, nonostante introduca delle nuove misure di tutela per questa categoria di lavoratori, deve però ancora trovare applicazione.
Il problema dello sfruttamento lavorativo delle persone con background migratorio, quindi, ha radici talmente profonde e sistemiche da essere parte dell’economia nazionale. Fornire una soluzione efficace, anche nel lungo periodo non è semplice, soprattutto se si continua a trattare il fenomeno migratorio come un’emergenza e a non considerare le persone migranti come titolari di diritti che devono essere garantiti come quello al lavoro, alla salute e a una giusta retribuzione.
Uno degli strumenti più utilizzati per contrastare questo fenomeno, quello del Decreto Flussi e il conseguente Click Day, continua a dimostrarsi inadeguato: pensato originariamente per disciplinare l’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il sistema dei flussi è utilizzato in gran parte per regolarizzare i lavoratori già presenti nel paese. E le persone che effettivamente riescono ad entrare grazie al Decreto flussi, non sono tutelate nei casi in cui poi non vengano assunte dal datore di lavoro e restano in una condizione di estrema vulnerabilità, senza avere la possibilità di regolarizzarsi in altro modo.
Infine, va considerato che, sia il dibattito pubblico che le politiche migratorie, tendono a concentrare l’attenzione sulla persona migrante priva di un titolo di soggiorno; in realtà la maggior parte dei lavoratori stranieri è in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Il focus, semmai, dovrebbe essere posto sulla cultura e sul sistema del mercato del lavoro e su un controllo più efficace e capillare della gestione dei rapporti di lavoro da parte delle aziende.
Lisa Zorzella