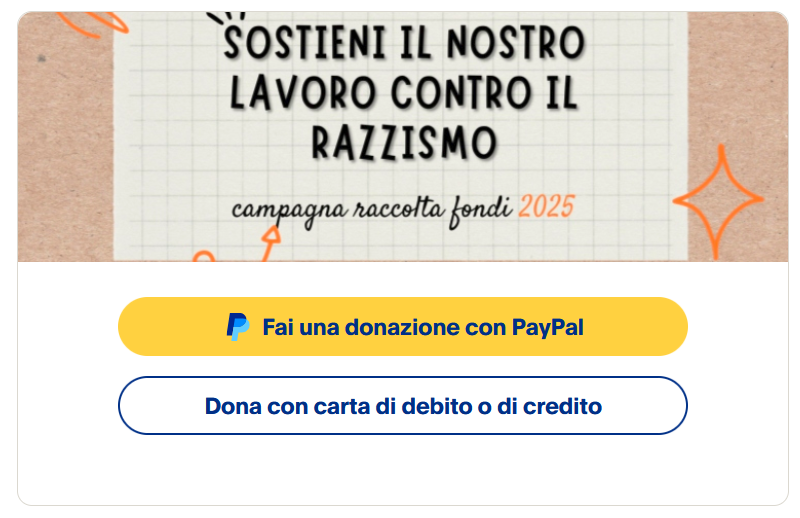Come le comunità di origine migrante si rappresentano, si raccontano e quali spazi per raccontare la propria storia, uscendo da visioni stereotipate, neocoloniali…? Che ruolo hanno i media, che tipo di discorso amplificano, quali esempi positivi e negativi di racconto di una comunità, o di un’istanza? Come coinvolgere chi fa parte delle comunità di riferimento e l’associazionismo “italiano” che si occupa di diritti (senza venirne fagocitati). Quali sono per le battaglie centrali, su cui mobilitarsi, cercare alleanze, mettere in discussione equilibri?
Sono le domande poste nel corso dell’evento “Attivismo e partecipazione” organizzato a Roma da Lunaria in collaborazione con l’associazione Gli Asini nell’ambito del Salone dell’editoria sociale. L’incontro, coordinato e facilitato dai giornalisti Eleonora Camilli e Giacomo Zandonini, ha coinvolto come relatori Zakaria Mohammad Ali – Archivio memorie migranti, Mary Babetto – Occhio ai media, Udo Enwereuzor – Cospe, Claudia Solana Inurreta – Trama di terre, Sediqa Moshtaq – Associazione di solidarietà donne per le donne, Omar Neffati – Italiani Senza Cittadinanza.
Appartenenza, comunità, confronto e spazi collettivi propri, una narrazione alternativa e indipendente da quella che tende a prevalere sui media mainstream e un’agenda politica autonoma, non condizionata da quella dei partiti e delle istituzioni, sono stati i temi al centro del dibattito che ha seguito la presentazione del lavoro svolto da Lunaria nel corso del progetto BABI (Better Advocacy for Better Inclusion).
Costruire una rappresentazione alternativa dei migranti e delle minoranze razzializzate è possibile, ha ricordato Mary Babetto di Occhio ai media, svelando i meccanismi di criminalizzazione e costruendo una narrazione propria, grazie a un’attività sistematica di monitoraggio dei media da un lato e alla produzione di strumenti di auto-narrazione.
“Avere uno spazio significa avere un potere” ha ricordato Zakaria Mohamed Alì dell’Archivio migranti, evidenziando che “creare comunità” non è semplice. Facendo riferimento alla sua comunità, quella somala, Zakaria ha evocato la distanza esistente tra l’esperienza vissuta dai primi migranti arrivati in Italia in aereo liberamente (vichiliri) e quella delle persone arrivate negli ultimi venti anni, costrette ad attraversare il deserto e il mare rischiando la propria vita (titanic). Per facilitare il confronto e la solidarietà è stata fondata l’Associazione culturale somala, creato un gruppo Whatsapp di circa 300 persone che vivono in diverse città italiane e promossa l’organizzazione della Settimana della cultura somala.
Un’esperienza diversa è quella di Udo Enwereuzor, di origine nigeriana, giunto in Italia per motivi di studio, che dopo l’esperienza svolta con l’Associazione degli Studenti Nigeriani, con l’Associazione degli Studenti Africani e con la nascita dell’associazione Africa Insieme a Pisa, ha scelto l’azione politica collettiva all’interno di un’organizzazione preesistente, il Cospe, legata alle politiche per lo sviluppo, rifiutando la forma dell’organizzazione comunitaria, privilegiata in alcune fasi da parte delle istituzioni nazionali.
Una scelta simile è quella fatta da Cristina Inurreta, vicepresidente di Trama di terre, associazione antirazzista storica di Imola, fondata da un gruppo di donne di diverse origini nazionali. L’invito di Claudia è quello di parlare di “comunità” in senso ampio considerando come elemento centrale quello dell’appartenenza al gruppo, a un collettivo, “la voglia di fare insieme”. “La contrapposizione noi/loro non funziona” e “serve un’assunzione di responsabilità di tutte e tutti: a scuola chi interviene per prevenire il matrimonio forzato? Serve fare formazione per i docenti e informazione sui diritti per gli studenti.”
La rappresentazione distorta delle e dei migranti è stata contestata anche da Sediqa Moshtaq – Associazione di solidarietà donne per le donne, arrivata in Italia nell’estate 2021, interessata a mettere in rete le donne della diaspora afghana che vivono in Italia, ma anche a mantenere relazioni con le donne rimaste in Afghanistan, lavorando sull’educazione sessuale e alla salute riproduttiva e sull’assistenza psicologica. Sediqua ha ricordato come molte delle donne afghane arrivate nel nostro paese siano altamente qualificate e desiderino costruire un percorso professionale corrispondente al loro livello di istruzione.
Per Omar Neffati, del movimento Italiani Senza cittadinanza, la costruzione di una nuova narrazione dei molti giovani di origine straniera che vivono in Italia passa dal racconto delle proprie storie e dall’elaborazione di un’agenda politica nuova più indipendente da quella dei partiti. Per certi versi “con Meloni: per noi non è cambiato niente”: la riforma della legge sulla cittadinanza, attesa da molti anni, non c’è stata, anche quando le maggioranze avevano un colore diverso. “Non dobbiamo fermarci, semmai costruire una nostra agenda, una nostra proposta di paese e una nostra idea di cittadinanza”.